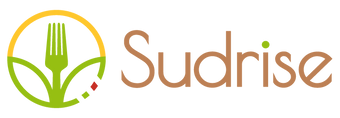Il rafano: una radice dalle innumerevoli proprietà
Con l’avvicinarsi del Carnevale i piccoli borghi lucani si preparano ad accogliere curiosi costumi carnevaleschi (le maschere cornute di Aliano, le mucche e i tori di Tricarico, i campanacci di San Mauro Forte e i Rumit di Satriano per citarne alcune). Intanto nelle strade si diffonde l’aroma pungente di una spezia il cui utilizzo risale a un’epoca piuttosto lontana. Stiamo parlando del rafano – conosciuto anche come cren o barbaforte –, pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Brassicaceae o Crucifere e nativa dell’Europa sudorientale e dell’Asia occidentale.
Un po’ di storia
Dal mondo antico ci sono giunte poche fonti che attestano l’impiego del rafano. In epoca greca e romana si pensava che la radice avesse potenti effetti afrodisiaci. Ovidio, nella sua Ars amatoria – composta tra il I sec. a.C. e il I sec. d. C. – consiglia l’utilizzo di filtri erotici vegetali a base di rafano. Inoltre, una descrizione della radice e dei suoi benefici è presente nell’enciclopedia naturalistica scritta da Plinio il Vecchio e nota come Naturalis Historia (I sec. d.C.). In particolare vengono menzionate le seguenti proprietà: stimolare l’appetito e la digestione, trattare i dolori e le infiammazioni, azione espettorante e purificante.
Le prime testimonianze certe dell’utilizzo del rafano risalgono al Medioevo quando esso si diffonde nelle farmacie dei conventi come rimedio fitoterapico. Ad esempio, Santa Ildegarda – erborista tedesca del XII secolo – raccomanda decotti ottenuti dal rafano per contrastare disturbi di natura medica. In un’epoca ricca di superstizioni e caratterizzata dall’emergere dell’alchimia (che alcuni studiosi considerano come precursore della chimica moderna), si diffonde inoltre la credenza secondo cui il rafano, per via del suo aroma particolare, avesse proprietà magiche, se non addirittura poteri diabolici.
Composizione e proprietà del rafano
Il rafano è ricco di componenti bioattivi, tra cui i glucosinolati e i loro derivati, e gli isotiocianati che conferiscono alla radice il sapore e il caratteristico odore pungente. Dal punto di vista nutrizionale, il rafano presenta un ridotto contenuto calorico ed è una fonte significativa di vitamine (B1 e C), di minerali e di polifenoli, che lo rendono un alimento dagli innumerevoli effetti benefici. La lista delle sue proprietà è piuttosto lunga: al rafano sono state infatti associate proprietà digestive, antianemiche, anticatarrali, antireumatiche, antiscorbutiche, bechiche, calmanti, depurative, diuretiche, espettoranti, eupeptiche, revulsive, rubefacenti, scialagoghe, stimolanti, stomachiche.
Il rafano nella cucina lucana
Oltre che come pianta officinale, il rafano gode da secoli di una grande fama come ottimo aromatizzante per insaporire i cibi. Una salsa piccante e appetitosa a base di rafano – nota come cren – è diffusa nella cucina slava e tedesca, ma anche in Inghilterra e nei paesi dell’Europa orientale. In Italia, invece, lo ritroviamo quasi esclusivamente in Trentino-Alto Adige e nel veronese, nonché in alcune regioni del Sud Italia. Il rafano è infatti uno dei tradizionali ingredienti gastronomici della cosiddetta cucina povera, ossia quella cucina tipica dell’Italia meridionale che costituisce una base della riconosciuta dieta mediterranea.
Secondo la tradizione il rafano si diffonde nel meridione in epoca normanna. Nello specifico, le caratteristiche climatiche di gran parte del territorio lucano e la presenza di numerosi corsi d’acqua, rendono le zone del lagonegrese, la Val d’Agri e l’area del Vulture particolarmente adatte alla coltivazione del rafano (non a caso una delle ipotesi etimologiche del termine suggerisce che la parola «rafano» significhi appunto «ravanello di mare»). Sull’Appennino lucano, invece, la radice sorge spontaneamente da gennaio a marzo, motivo per cui è spesso presente sulle nostre tavole durante il periodo di Carnevale.
La radice intera del rafano è quasi totalmente priva di odore, ma una volta tagliata, o ancora meglio grattugiata, emana un’essenza molto piccante. La presenza di solfuri rende l’olio volatile sprigionato dal rafano piuttosto irritante per gli occhi e per le mucose nasali.
Ancora oggi la radice viene grattugiata sulla pasta al sugo di pomodoro, ma anche sulla pasta e legumi; alcuni chef la utilizzano persino per condire il pesce alla griglia. Una tradizionale ricetta lucana a base di rafano, tipica di questo periodo, è la rafanata, una specie di frittata (con patate, pecorino, e con l’aggiunta facoltativa di pezzi di salsiccia). Il piatto viene spesso servito con peperoni cruschi sbriciolati e accompagnato da un vino robusto e di carattere come l’Aglianico del Vulture.
Sei curioso di assaporare questa specialità? Vieni da Sudrise a scoprire l’inconfondibile sapore del rafano di Montemurro!

La rafanata, piatto tipico della Basilicata durante il Carnevale
Lo sapevi che…
Nel celebre romanzo Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi troviamo degli interessanti riferimenti al carnevale lucano. Durante il suo confino ad Aliano, lo scrittore entra in contatto con la cultura e la tradizione contadina lucana, restituendoci un brillante resoconto antropologico. Levi descrive dettagliatamente le famose maschere cornute di Aliano tratteggiandone non solo i caratteri folkloristici, ma anche il profondo significato simbolico legato all’identità locale.
Tradizionalmente la maschera è uno strumento che consente all’individuo – anche se soltanto per breve tempo – di celare la propria identità quotidiana permettendogli di interpretare un ruolo che fuoriesce dalle tradizionali convenzioni sociali.
Le maschere del carnevale alianese – fatte di legno e cartapesta – diventano dunque metafora della durezza e della tenacia della vita rurale e contadina. Il gioco del travestimento è una sorta di liberazione attraverso cui l’individuo ribalta le gerarchie sociali per resistere a una realtà opprimente: quella della vita contadina del Sud Italia segnata da sofferenza, miseria e alienazione.
In un’atmosfera carnevalesca di euforia e divertimento, non può mancare il buon cibo locale. Tra le pietanze lucane tipiche di questo periodo, Levi cita il rafano, tradizionalmente soprannominato il “tartufo dei poveri” per la sua diffusione nella cucina di tradizione contadina. Grazie all’elevato apporto energetico, infatti, il rafano veniva consumato in abbondanza dai contadini che necessitavano di forza ed energia per portare a termine le lunghe ed estenuanti giornate lavorative. Il rafano diventa dunque anch’esso simbolo della vita rurale e della resistenza del popolo contadino meridionale che, nonostante le difficoltà, si aggrappa alla terra e ai prodotti che essa offre.

Le maschere “cornute” di Aliano - Fonte: Basilicata Turistica