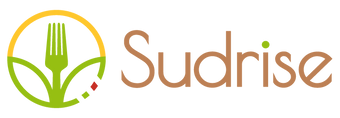Rinascita lucana: la Pasqua tra riti, simboli e sapori
Con l’avvicinarsi della Pasqua, la Basilicata si trasforma in un palcoscenico vivente di antiche tradizioni, radicate in un patrimonio culturale e religioso di straordinaria ricchezza. Questo periodo dell’anno non celebra soltanto la cucina tipica, ma si anima di riti e simboli che raccontano la forza della fede, l’identità locale e la memoria collettiva. La Pasqua lucana diventa così un momento di intensa partecipazione, capace di unire la comunità in una rinnovata celebrazione della vita, della speranza e della rinascita.
La fede in scena: le rappresentazioni Sacre della Settimana Santa
Durante la Settimana Santa, i borghi lucani si trasformano in veri e propri teatri a cielo aperto. Le rappresentazioni Sacre rievocano la Passione di Cristo, in una drammatizzazione collettiva che coinvolge l’intera comunità.
Tra le più suggestive si distinguono quelle dell’area del Vulture-Melfese. A Barile, ad esempio, prende vita uno dei riti più antichi e affascinanti della regione, dove sacro e profano si mescolano in una narrazione potente e corale: vi è coinvolta anche la figura della Zingara, una giovane fanciulla adornata di gioielli che, secondo la tradizione, avrebbe procurato i chiodi per la crocifissione di Gesù. A Maschito, altro borgo di origine arbëreshë, la rappresentazione si arricchisce di ulteriori figure simboliche come i “mori”, creando un interessante intreccio tra devozione religiosa e patrimonio etno-antropologico.
Anche in centri come Ripacandida, Montescaglioso, Atella, Rapolla e Venosa, la Settimana Santa rappresenta un’occasione di profonda partecipazione comunitaria. Le popolazioni locali diventano protagoniste attive della narrazione sacra, dando vita a potenti espressioni di spiritualità condivisa.
© Graphic Revolution Melfi. La Zingara, durante la processione della Via Crucis a Barile.
Primavera e rinascita: il risveglio della natura e della vita
Per i cristiani, la Pasqua non segna solo la fine del periodo di digiuno e penitenza, ma celebra soprattutto la resurrezione di Cristo. La festività coincide con l’arrivo della primavera, quando la natura si risveglia, portando con sé una promessa di rinnovamento e speranza.
Un simbolo particolarmente evocativo della Pasqua lucana sono i “sepolcri”, germogli di grano coltivati al buio e poi portati in chiesa come offerta rituale. Questi bianchi fili vegetali rappresentano un gesto propiziatorio legato alla fertilità della terra e al ciclo vitale della natura. Una tradizione che affonda le sue radici nei miti dell’antichità classica, come quello di Proserpina, figlia di Cerere, rapita da Plutone e costretta a restare prigioniera nell’oltretomba fino al suo ritorno alla luce con l’arrivo della primavera.
Nelle comunità rurali, il periodo pasquale – che coincide con l’inizio della primavera – segnava un momento cruciale: dall’esito del raccolto dipendeva la sopravvivenza e il benessere dell’intera comunità contadina. Non sorprende, quindi, che i cibi cerimoniali di questa ricorrenza siano intrisi di simbolismi legati alla vita e alla fertilità. Tra tutti, l’uovo emerge come emblema per eccellenza della vita nascente: decora torte pasquali e arricchisce ricette tradizionali, assumendo una forte valenza augurale di prosperità e abbondanza.
Sapori di Pasqua sulla tavola lucana
Ogni festa che si rispetti porta con sé una ricca tradizione gastronomica. In Basilicata, la Pasqua si celebra anche a tavola, con una cucina autentica, figlia della cultura contadina, che oggi si arricchisce di raffinate sfumature contemporanee.
Il pranzo pasquale inizia con una frittata cotta sul caminetto, utilizzando i tradizionali tegami di un tempo: un piatto semplice che segna il primo momento di condivisione familiare, dando il via a un vero e proprio tripudio di sapori. A seguire arrivano in tavola i rascatiedd’, tipica pasta fresca lucana, condita con sugo e abbondante ricotta salata. Durante la Settimana Santa, un’alternativa altrettanto apprezzata sono i ferricelli, conditi con mollica di pane croccante saltata in olio e aglio.
Come in molte regioni italiane, anche in Basilicata l’agnello alla brace è uno dei protagonisti del pranzo pasquale. Il suo consumo è legato ad antiche tradizioni religiose. Nel Vecchio Testamento, l’agnello compare come vittima sacrificale, un rito che il Cristianesimo ha reinterpretato identificando Cristo stesso come l’Agnello di Dio. Questo piatto assume così un profondo valore simbolico, richiamando il sacrificio, la redenzione e la rinascita.
Tra le preparazioni lucane più caratteristiche del periodo pasquale, spiccano i calzoni – noti nei dialetti locali come scarcedd’ o pastizz (come a Pisticci) – ripieni di toma, uova, ricotta, carne di maiale o salsiccia. Esistono anche varianti con bietole o cipolle fresche, oltre a versioni dolci con ricotta.

Il calzone lucano
Inoltre, non può mancare il piccillato (o picciddato), una ciambella di pasta lievitata che può essere dolce o salata, liscia o intrecciata, e tradizionalmente decorata con uova intere, avvolte nei lembi di pasta. Le sue origini risalgono probabilmente all'incontro tra la cultura contadina lucana e quella arbëreshë. Viene solitamente preparato in abbondanza, per essere condiviso con amici e parenti.
Pasqua in dolcezza
Tra i dolci pasquali più rappresentativi della Basilicata, celebri sono le scarcelle, preparazioni di pasta frolla diffuse in gran parte del Meridione e in alcune zone dell’Italia centrale. L’elemento distintivo è l’uovo sodo, incastonato nell’impasto. Spesso decorati con granelle o corallini colorati, questi dolci assumono forme varie e fantasiose. La forma più iconica è quella di una figura femminile, conosciuta come pupa, che un tempo le nonne regalavano alle nipotine come augurio di fortuna e abbondanza. Le scarcelle possono assumere anche le forme di cuori, colombe, cavallucci o cestini.

La pupa, una delle versioni più originali delle scarcelle.
In alcune zone della Basilicata, questi dolci si sono evoluti in semplici biscotti a forma di ciambella, ricoperti di glassa di zucchero (naspro) e consumati a colazione o come dessert. In ogni variante, l’uovo continua a essere il cuore simbolico e gastronomico.
Anche dolci di origine più recente hanno trovato posto sulle tavole lucane. La colomba pasquale, con la sua forma iconica che richiama il simbolo di pace e resurrezione, è ormai un classico della Pasqua italiana e non solo. Accanto a essa trionfa la pastiera, regina indiscussa delle tavole del Sud. Nella sua versione lucana, si distingue per una maggiore semplicità rispetto a quella napoletana, pur conservandone i sapori essenziali: ricotta, grano, canditi e fiori d’arancio.
Una dolce sorpresa: l’uovo di Pasqua
Cuore pulsante della Pasqua, l’uovo è da sempre simbolo di fertilità e rinascita. Già nelle culture pagane rappresentava il ciclo della vita e il risveglio della primavera. Il principio Omne vivum ex ovo – “Tutti i viventi nascono da un uovo” – era una formula propiziatoria che gli antichi Romani recitavano seppellendo un uovo dipinto di rosso nei campi, affinché il raccolto fosse abbondante.
Con il Cristianesimo, l’uovo assume un significato ancora più profondo: il suo guscio chiuso, solo in apparenza inerte, custodisce una vita latente pronta a sbocciare. Non a caso, la Pasqua cade tra il 25 marzo e il 25 aprile, nella prima domenica successiva al plenilunio che segue l’equinozio di primavera. In questo periodo dell’anno la natura si risveglia dopo la “morte” dell’inverno e, nella fede cristiana, la Pasqua diventa il simbolo della resurrezione di Cristo: la vita che rinasce dalla morte.
Non stupisce, dunque, che l’uovo sia protagonista assoluto dei dolci rituali della Pasqua lucana: dalle pupe alle scarcelle, dove appare incastonato come un piccolo tesoro, fino alle moderne e universali uova di cioccolato con sorpresa, che ne richiamano la forma e ne attualizzano il significato simbolico. In tutte le sue forme, l’uovo continua a raccontare la vita, la rinascita e la speranza. Donarlo, ancora oggi, è un gesto carico di augurio, abbondanza e rinnovamento: un segno semplice ma potente della gioia pasquale, capace di unire le generazioni, attraversare i secoli e rinnovare, ogni primavera, il fascino e il mistero della vita.